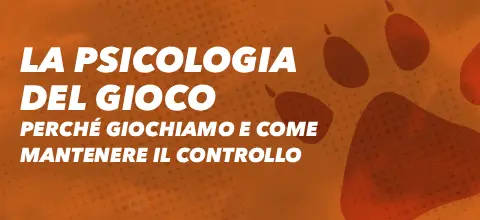
La psicologia del gioco: perché giochiamo e come mantenere il controllo
Conoscere i meccanismi mentali ed emotivi che guidano il comportamento delle persone quando giocano è fondamentale per riconoscere i segnali di pericolo e mantenere un approccio sano e consapevole al gioco.
Ma come fare a comprendere i fattori psicologici che influenzano il giocatore quando piazza puntate su slot, tavoli dal vivo o eventi sportivi? In questo articolo, puramente informativo, ti aiuteremo a capire cosa si attiva nel cervello quando si gioca, gli elementi di rischio e i segnali d’allarme, oltre a indicarti i servizi che offrono supporto e le strategie per far sì che la situazione non sfugga di mano.
I meccanismi psicologici del gioco d’azzardo
La psicologia legata al gioco è un complesso mix di meccanismi di ricompensa, distorsioni percettive e trappole cognitive. Non è una semplice questione di "vizio", di mancanza di volontà o di irrazionalità, ma di processi psicologici e neurobiologici che alterano la percezione, il processo decisionale e la gestione delle emozioni. Tra questi meccanismi, in grado di trasformare un semplice passatempo in una dipendenza comportamentale, i più importanti sono:
Rinforzo intermittente: individuato in origine dallo psicologo americano Burrhus Frederic Skinner, il rinforzo a intermittenza è un meccanismo per cui un comportamento viene appreso e mantenuto più tenacemente quando la ricompensa è imprevedibile e casuale, non quando è costante. Uno dei motori più potenti della dipendenza da gioco è proprio questo: il cervello del giocatore impara che, anche se le perdite sono frequenti, una vincita può arrivare in qualsiasi momento e questa speranza lo spinge a continuare a giocare.
Dopamina e adrenalina: ogni volta che si vince, il cervello riceve una forte scarica di dopamina, generando euforia e attivando il sistema della ricompensa. La fase di attesa alimenta anche l’adrenalina, rendendo l’esperienza eccitante e difficile da interrompere. Questo mix chimico spinge il giocatore a continuare a giocare per rivivere queste sensazioni piacevoli e sfuggire alla noia o a stati di ansia e depressione.
Minimizzazione delle perdite ed enfasi sulle vincite: il cervello umano tende a ricordare con maggiore enfasi gli eventi positivi e a dimenticare quelli negativi. Dunque, quando si gioca, si tende a focalizzarsi sulle vincite e a minimizzare, giustificare o considerare come “quasi vincite” le perdite. Ciò alimenta la convinzione che si possano recuperare le perdite e spinge a continuare a giocare anche quando bisognerebbe fermarsi.
Illusione di controllo: molti giocatori sono convinti di poter influenzare l'esito di un evento puramente casuale attraverso abilità, rituali o strategie personali. Questa illusione dà un falso senso di potere, spingendo a credere di essere in grado di vincere e, quindi, a continuare a giocare nonostante le perdite.
Fallacia del giocatore: è la credenza irrazionale che eventi passati, come ad esempio una lunga serie di sconfitte, possano influenzare l'esito di eventi futuri indipendenti. Il giocatore è erroneamente convinto che, dopo una serie di risultati sfavorevoli, la probabilità che si verifichi l'esito opposto aumenti. Questo pensiero porta a puntare di più proprio quando si sta perdendo, nella speranza di un'imminente inversione di tendenza, innescando spesso il cosiddetto "inseguimento delle perdite".
Riconoscere questi meccanismi è il primo passo per mantenere il controllo sul gioco e prevenire l’insorgere di abitudini problematiche.
I fattori di rischio individuali
Il rischio di sviluppare comportamenti problematici legati al gioco è influenzato da un’interazione di diversi fattori individuali, ambientali e psicologici che possono aumentare la vulnerabilità di una persona. Di seguito trovi un elenco di quelli più rilevanti.
Impulsività: la tendenza ad agire rapidamente senza valutare le conseguenze, ovvero l’impulsività, rende difficile resistere alle tentazioni e a posticipare le gratificazioni. Dunque le persone impulsive sono più propense a comportarsi in modo rischioso nel gioco.
Difficoltà emotive ed eventi stressanti: per molti il gioco è un modo per non affrontare emozioni negative, come noia, tristezza, ansia o depressione, o situazioni difficili, come problemi familiari o lavorativi. Giocare diviene una via di fuga illusoria da questo tipo di scenari e, allo stesso tempo, innesca un circolo vizioso in cui il gioco stesso diviene fonte di emozioni negative e situazioni stressanti.
Traumi: la dipendenza da gioco, come altri tipi di dipendenza, può derivare da esperienze traumatiche vissute da bambini, come abusi o violenze domestiche, o da adulti, come la perdita di una persona cara o del lavoro. In questi casi, il gioco può essere visto come una forma di automedicazione per alleviare la sofferenza emotiva.
Problemi economici: le difficoltà in ambito finanziario possono essere non solo una conseguenza ma anche una causa della dipendenza da gioco. Le persone con problemi economici, infatti, a volte cominciano a giocare perché sperano di guadagnare “soldi facili” e rimettere, così, le cose a posto. Ciò porta nella maggior parte dei casi al peggioramento della situazione e innesca il meccanismo di “inseguimento delle perdite”.
Isolamento sociale: come per i problemi economici, anche l’isolamento può essere causa ed effetto del gioco problematico. Il sentirsi soli e/o esclusi può aumentare la propensione al rischio e quindi al gioco, ma allo stesso tempo chi gioca tende a isolarsi per nascondere questa abitudine, percepita come qualcosa di cui vergognarsi.
Presenza di altre dipendenze (o comorbilità): una dipendenza può abbassare le inibizioni e aumentare l'impulsività, rendendo più probabile lo sviluppo di un'altra. Chi soffre già di dipendenze (da sostanze o comportamentali) manifesta, quindi, una maggiore propensione a sviluppare disturbi legati al gioco.
Questi fattori individuali, combinati con altre variabili ambientali e familiari, contribuiscono a delineare il profilo di rischio per il gioco patologico. Per capire se tu o chi ti sta vicino ha sviluppato o sta sviluppando una dipendenza dal gioco, leggi la sezione Come riconoscere i segnali del gioco problematico del nostro articolo Quando chiedere aiuto: risorse e supporto per il gioco problematico.
Strategie per mantenere il controllo
Per tenere sotto controllo le proprie abitudini di gioco ed evitare di sviluppare una dipendenza si possono adottare alcune strategie pratiche.
Imposta limiti di tempo e denaro: uno dei modi più efficaci per non perdere il controllo è fissare un limite, sia per il tempo dedicato al gioco sia per la quantità di denaro da spendere, prima ancora di iniziare a giocare. Definire un budget da dedicare al gioco e utilizzare timer, orologi e promemoria può aiutare a non perdere la cognizione dei soldi spesi e del tempo trascorso giocando.
Fai pause regolari: per mantenere la lucidità e prendere decisioni più razionali, è utile allontanarsi dal gioco a intervalli regolari. Durante lunghe sessioni di gioco, infatti, si può cadere in uno stato di “trance”, che le pause possono interrompere, permettendo di rivalutare la situazione con maggiore distacco.
Dedicati ad altre attività: cerca alternative di svago come attività fisiche, hobby o momenti di socializzazione per mantenere il gioco nel puro ambito del divertimento.
Chiedi aiuto: se senti di star perdendo il controllo sulle tue attività di gioco, parlane con una persona di fiducia, un familiare o uno specialista per farti aiutare ed evitare di sviluppare una dipendenza.
Queste strategie aumentano la consapevolezza e la capacità di scelta, favorendo un rapporto equilibrato con il gioco e proteggendo il proprio benessere psicologico.
Dove chiedere aiuto
Quando emergono i primi segnali d’allarme relativi alle proprie abitudini di gioco, un intervento tempestivo può fare la differenza nel prevenire problemi più seri. Esistono centri di ascolto, professionisti e servizi dedicati che possono aiutare in questo senso, offrendo supporto emotivo e pratico e aiutandoti a capire se sia il caso di smettere di giocare.
Il Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione il Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al Gioco d’Azzardo (TVNGA), 800 558822, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16.
A livello regionale esistono i SERD (Servizi per le Dipendenze), che generalmente si trovano presso le ASL e offrono supporto e interventi mirati per le persone con problemi di gioco e per le loro famiglie.
Puoi trovare maggiori informazioni sulle risorse nazionali per il supporto al gioco patologico nel nostro blog e sulle associazioni di supporto per chi soffre di disturbi legati al gioco sul nostro sito dedicato al gioco responsabile LeoSafeplay.
Conclusioni
Il gioco, pur essendo una forma di intrattenimento, nasconde rischi che possono trasformarlo in un problema serio se non viene gestito con consapevolezza e responsabilità. Per questo motivo è importante conoscere i meccanismi psicologici e i fattori di rischio che possono rendere più vulnerabili allo sviluppo di una dipendenza dal gioco.
È fondamentale informarsi e monitorare i propri comportamenti, prestando attenzione ai segnali di rischio come l’aumento del tempo e del denaro spesi, la difficoltà a smettere o l’utilizzo del gioco come valvola di sfogo.
Se avverti che il gioco sta prendendo il sopravvento su di te o su una persona cara, ricorda che parlarne e rivolgersi a professionisti qualificati o a gruppi di supporto non è un segno di debolezza, ma un atto di coraggio e un passo decisivo per ritrovare il proprio benessere e quello della propria famiglia.